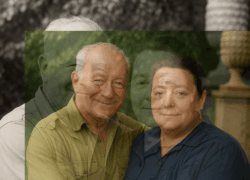Punti di vista
Sembrerebbe che, guardando i punti di vista altrui, avessimo già visto tutto.
Ma attenzione: quelli sono i loro punti di vista, non i vostri. Pertanto, anche se là fuori ci sono miliardi di fotografie di luoghi visti e rivisti nel mondo, c’è ancora uno che non è stato visto: il vostro.
L’uomo è persona, è maschera, è tempo, è storia.
Ormai tutto il mondo è storia, perché è stato rappresentato ed è dentro la nostra memoria. Se oggi vi fate un giro su internet, potrete trovare immagini di ogni luogo del mondo, dai quattro punti cardinali: dal nord o settentrione, al sud o mezzogiorno o meridione, dall’est o levante od oriente, e all’ovest o ponente od occidente.
Avrete visto pure l’immagine della Terra fotografata dalla Luna.
Come diceva Luigi Ghirri:
“la foto che contiene tutte le foto del mondo”.
Dobbiamo arrivare a questa consapevolezza: l’uomo è immagine, “simbolo”.
Che significa? Quando diciamo che l’uomo è persona, e questa persona è di fronte a noi, non ho solo lui davanti a me, ma ho davanti tutte le sue relazioni, tutte le sue domande, tutto il suo mistero. Tanto più, normalmente, queste domande, queste relazioni per quella persona sono forti, e se l’uomo, quando vive di relazioni intense, normalmente conosce anche il dolore. Esiste un dolore non solo fisico; e se questi dolori si manifestano, li rendiamo visibili o cerchiamo di mascherarli.
Quando incontri davanti a te questa persona e guardi il suo volto, la sua immagine, tu lo vedi, ci tieni a lui e senti la sua sofferenza. Gli chiedi: “Come stai?”, ed egli ti risponde: “Benissimo, grazie”. Egli tace il suo dolore.
Ci domandiamo il perché: è perché egli sa (consapevolmente o inconsapevolmente) che di fronte a lui c’è uno specchio, e guardare nello specchio la propria sofferenza è lacerante. Non solo richiede un atto di coraggio, ma anche un grande atto di umiltà: riconoscere e comprendere che a tutto c’è una cura.
Tutto il problema della vita sta nel fatto che ciò che ho davanti è solo una parte del visibile. L’uomo non è solo ciò che vedo: realmente esiste una grande parte di “un altro” in lui.
I Greci dicevano che una parte dell’uomo è simbolo, che significa “mettere insieme”, come a intendere che metà di lui appartenga a un altro.
Il simbolo1La parola “simbolo” deriva dal greco antico “mettere insieme” e si riferisce a una “tessera di riconoscimento” o “tessera hospitalitatis”. Questa usanza prevedeva che due individui, famiglie o gruppi, spezzassero una tessera di terracotta o un anello, conservando ciascuno una parte come segno di un accordo o alleanza. Da qui deriva anche il significato di “patto” o “accordo”, poiché il perfetto incastro delle due metà dimostrava l’esistenza dell’intesa., per i Greci, era una specie di contratto che si stabiliva tra uomini tramite tessere o sigilli in terracotta spezzati a metà, a significare un’alleanza. (Un esempio moderno di simbolo simile potremmo suggerire quello delle medagliette con il cuoricino spezzato a metà.)
Essendo l’uomo “simbolo, persona, immagine”, cercheremo di leggere, nella storia della fotografia, le immagini e gli autori che ci fanno entrare in queste relazioni e ci svelano il loro destino e il nostro. Perché questo è il dato fondamentale del mistero dell’immagine.
Quando le immagini sono, o diventano, un riferimento nel tempo, esse si pongono in relazione misteriosa con qualcosa che permane, che nessun tempo né progresso scientifico potrà mai far diventare o rendere obsoleto.
Tra questi riferimenti ci sono i colori fondamentali.

Annunciazione 1435 di Beato Angelico – Madrid, Museo del Prado.
Citazione di Dante:
“dolce color d’oriental zaffiro”
riferendosi a un cielo sereno e luminoso.
Citazione: dalla Divina Commedia, Canto I – Purgatorio
Paris, Texas, di Wim Wenders. Nella scena finale, Travis riporta il bambino dalla madre. Li lascia ricongiungersi, poi si allontana. Perché, se non c’è nessuno che ti ama, non c’è nemmeno una casa. E allora è meglio rimettersi in viaggio, _“On the road”.
È un addio al calare della giornata. Il tramonto è quasi finito: l’orizzonte è rosso, il cielo si stende in un blu profondo, e sotto il palo della luce affiora un verde intenso. Tre colori simbolici, fondamentali, scelti non a caso: “i colori hanno significati molto precisi”.
Wenders, fotografo oltre che regista, conosce bene il linguaggio della luce. Negli anni ’70 e all’inizio degli ’80 studia i fotografi americani che avevano fatto del colore il loro campo di ricerca, immortalando tramonti e scene crepuscolari. Conosce bene come trasformare un’inquadratura in un’emozione, far dialogare le luci artificiali con certe atmosfere naturali.
Paris, Texas
Scena finale, (Wim Wenders, 1984)
Tornando alle immagini che mantengono un significato nel tempo, nel caso di Wenders possiamo dire che nella sua visione c’è tutta la sapienza del simbolico. In quei pochi istanti, dove al finire di un tramonto, esiste un rosso vivo — quasi puro — si accende, mentre il celeste diventa un blu intenso, richiamando quella espressione dantesca “dolce color d’oriental zaffiro”. Il verde, sotto un palo di luce al neon, non è casuale: è un colore artificioso. Dopo un intenso sguardo verso questo tramonto, il personaggio del film si rimette in viaggio, avvolto da questi colori fondamentali.
I tecnici hollywoodiani potrebbero dire: «Non ti hanno insegnato, ignorante di un tedesco, che sotto i pali della luce al neon compaiono dominanti colorate? Noi, con le nostre lampade cinematografiche, possiamo correggere queste dominanti». Invece Wenders la lascia, la dominante verde. Sarà che non sa che esistono i filtri cinematografici? Che possiamo adoperare dei riflettori da ventimila watt per produrre una luce “corretta”? O sarà, guarda caso, che vuole proprio quella luce verde, mentre al tramonto ci sono il blu e il rosso.
…raccolti diffusi da G. Chiaramonte.
Tutto questo appartiene alla storia dell’immagine. Due libri di Wenders fotografo — Una volta e L’atto di vedere — lo testimoniano. Dopo tutta la fama e la fortuna conquistate con i suoi straordinari film, Wenders continua, dopotutto, a fare fotografie.
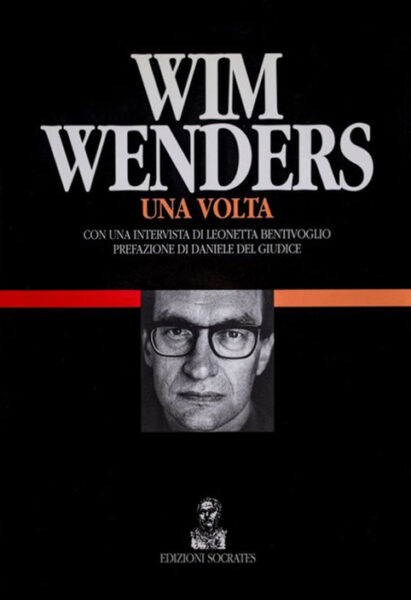
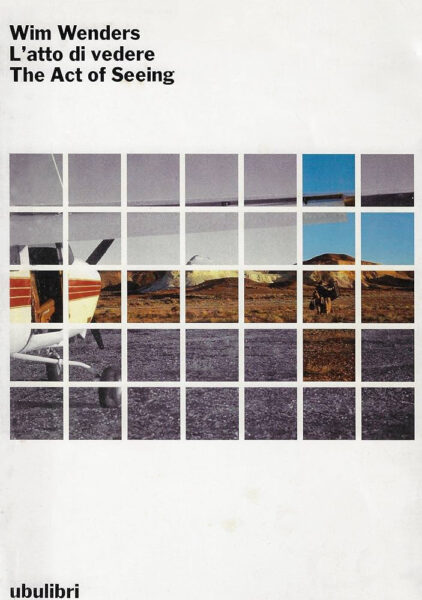
Il percorso è comprendere che non si tratta di una questione di potere o di sapere. Certo, le biografie degli artisti sono importanti, ma non ti cambia la vita sapere quando è nato o quando è morto un artista: queste informazioni servono a collocarli in un determinato tempo storico. Ciò che conta davvero è ciò che si trova dietro le loro opere. Comprendere l’arte significa “estendere la loro visione”.
Non trovo interessante sapere quando è nato o morto Felice Beato; ciò che mi interessa è che, a soli ventitré anni, partecipò alla guerra di Crimea insieme al suo socio James Robertson. Questo avvenne subito dopo il ritorno di Roger Fenton in Gran Bretagna e, rispetto alla documentazione di Fenton, le foto di Beato rappresentano una visione più cruda e cruenta della devastazione della guerra.

Roger Fenton – Crimea “Valle dell’Ombra della Morte”

Felice Beato – Crimea la battaglia del Grande Redan, il 18 giugno 1855
È altrettanto interessante scoprire che, dall’altra parte della barricata, tra le forze russe, si trovava un giovane tenente di nome Lev Tolstoj. Questa esperienza avrebbe poi ispirato la sua grande opera letteraria, il celebre romanzo “Guerra e pace”.
Lev Tolstoj
Guerra e pace
E’ tra il 1851 e il 1853 che Lev Tolstoj, seguendo il fratello maggiore Nikolaj, partecipa alla guerra nel Caucaso, inizialmente come volontario e successivamente come ufficiale d’artiglieria. Quando nel 1853 scoppia la guerra russo-turca, Tolstoj chiede di essere trasferito in Crimea, dove difenderà il bastione di Malakoff durante l’assedio di Sebastopoli. Dopo ripetuti e vani tentativi dei russi di rompere l’assedio, Sebastopoli viene abbandonata, portando alla sconfitta della Russia, il 9 settembre 1855.
Da questa esperienza nascerà una serie di racconti di guerra, che condurranno Tolstoj a una delle riflessioni più grandiose della sua produzione letteraria: Il romanzo “Guerra e pace”.
Robertson & Beato, Vista di Sebastopoli, scattata da Malakoff 1855.
Se abbiamo compreso che il problema della fotografia è il tempo, in ogni momento di queste storie si presenta una scelta: o ci sei, o non ci sei. Da questa affermazione non si sfugge: è una decisione legata all’esistenza.
Perché la foto, quando la farete — se la farete — sarà un istante in cui sarete soli, in un tempo solamente vostro. Potreste trovarvi in uno dei luoghi più fotografati al mondo, con più di tremila persone intorno a voi a scattare, ma il vostro click, in quel preciso momento, sarà solo vostro. Farete una foto che, proprio lì, nessuno ha mai fatto. Perché se tutto è in relazione, nulla è mai uguale. E con questo esserci, con questa attitudine, potreste ribaltare qualsiasi omologazione, qualsiasi alienazione, che equivale — per definizione — a ribaltare il concetto stesso di schiavitù visiva e non solo. Con le nostre identità uniche e irripetibili possiamo trovare la via per diventare ‘Noi’.
Ci sono luoghi dove i fotografi continuano a realizzare grandi immagini. Cosa cambia? Cambia il tempo. Ma, in quel caso, “il tempo sei tu”.